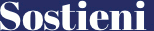I segreti di quella piazza Caprera che 50 anni fa è stata l’anima della mia adolescenza
Premesso che c’era una volta è, nell’immaginario collettivo, più bello di qualsiasi inquietante richiamo alla realtà del momento e che quest’effetto latamente (falsamente?) poetico nasce da un espediente retorico, c’è da dire qualcosa per uscire dall’equivoco della ricostruzione dei bei tempi che furono. Il passato, anche recente, ha le sue ombre: tali sono stati il muro di Berlino, il delitto Moro, gli anni di piombo, fino ad arrivare alla vergogna dell’Olocausto che ha coinvolto non solo il popolo tedesco ma anche quello italiano.
Il mio c’era una volta di oggi riguarda una piazza di Roma, oggetto al presente se non proprio di scempio, di un degrado legato a un momento storico che, come quello presente, mi pare possa caratterizzarsi come involutivo. È mio convincimento peraltro che questa involuzione abbia radici nel passato e che, prima ancora degli adolescenti di oggi, siano stati bamboccioni i loro genitori, se non anche i loro nonni. Da questo punto di vista i sedicenni, i diciottenni e i ventenni che schiamazzano e sporcano le piazze romane (piazza Caprera, piazza Mincio, piazza Euclide secondo quanto si legge) sono frutto di un’educazione sbagliata che sfocia nel dileggio e nel disprezzo della ricchezza comune. D’altro canto, se i figli sporcano piazza Caprera, i padri hanno lasciato che l’acqua alta (o altissima) sommergesse una città come Venezia che non solo il mondo ma perfino gli alieni (posto che vi siano) ci invidiano.
Questo mio articolo su piazza Caprera, delizioso angolo del quartiere Trieste, vuol dare un’anima, un vissuto a un luogo della mia adolescenza. E in questo senso va letto. Se il nome non avesse rievocato l’epopea garibaldina, possibilmente una piazza Caprera a Roma non sarebbe mai nata. Ci sarebbe stata sì e no una piccola via, più o meno anonima, di quelle che, grazie a un’iscrizione su una lastra di travertino, servono a ricordare l’esistenza di un luogo, che tanti neanche sanno dove esattamente si trovi. Invece se n’è fatta un’elegante rotonda all’incrocio di via delle Alpi con via degli Appennini che conducono a deliziose stradine secondarie su cui affacciano villini e palazzine. Sono abitazioni di un certo tono che, senza essere immerse nel verde, sono comunque da indicarsi come tipiche di un’architettura che ha qualche rispetto per la natura del luogo, vorrei dire per il genius loci, divinità che ha tutto il diritto, per citare Montale, di corrucciarsi quando sia violata.
Descrivendo il quartiere dove aveva abitato, fino al 1922, la scrittrice Paola Masino, compagna di Massimo Bontempelli, così si esprime nel suo romanzo “Periferia”, edito per la prima volta da Bompiani nell’ormai lontano 1933:
Le sue strade sono file di villini con giardinetti coltivati a ghiaiolina bianca e glicine; di case a cinque piani velate da una leggera tinta uovo sbattuto, di cancelli e porte con targhetta d’ottone brillante, su cui all’infinito si legge Comm. Cav. Rag. Col Gr. Uff. Avv. Ten. S. Ten. Prof. Dott. A fianco alle targhette c’è il campanello di porcellana bianca, o, ai cancelli, la campanella di ferro battuto. Gli abitanti di tali case hanno bisogno di poche botteghe e oneste.

Per chi abbia a mente la piazza Caprera di cinquant’anni e più fa, la descrizione vale per certi versi più delle foto d’epoca poste a corredo di questo articolo e che mi sono state messe a disposizione degli amici Massimo e Alba Floquet, che naturalmente ringrazio.
Le foto infatti non fanno vedere, anche per i limiti della tecnologia del tempo, “la tinta uovo sbattuto” né “il campanello di porcellana bianco” e neanche la “ghiaiolina”, che pure l’occhio, fatto avvertito, riesce qua e là a indovinare. Queste stesse foto peraltro dicono qualcosa che la penna pur efficace della Masino tralascia di dire, come il fatto per esempio che la piazza non fosse asfaltata (siamo del resto agli inizi del secolo passato probabilmente alla vigilia della prima guerra mondiale), cosa che giustifica il normale utilizzo del calessino [foto 1] da parte del signor Carlo Cantoni il quale vi abitò con la sua famigliola. Il gruppo di famiglia [foto 2] è carinamente schierato, a fare educatamente mostra di sé, sulla scalinata del villino che affacciava ed affaccia tuttora sulla piazza, sia pure lievemente modificato (sopraelevato per la precisione) rispetto a com’era in origine.

Ad alcuni di questi personaggi possiamo dare un nome. In alto a destra la figura compassata, per non dire austera, del padrone di casa, il baffuto Carlo Cantoni; uno o due gradini più giù, vestita di scuro sua moglie Ester; appoggiato al pilastro con aria più gioviale e disinvolta il genero Attilio, accanto a quella che allora sembra fosse ancora la sua fidanzata, Ghita Cantoni, figlia di Carlo e di Ester. Più difficile dare un’identità ai due bambini e alla donna che, senza cappellino, emerge alle spalle dei fidanzati e che probabilmente è una tata. Siamo nel 1912 o 1913, quando sono da poco terminati i lavori della piazza, punto in cui allora “moriva” via Alessandria. Più di un secolo fa! Quel vissuto di gozzaniana memoria, dove gli oggetti vintage e di modernariato erano le buone cose di pessimo gusto, non c’è più e non è detto che ciò sia un male. Ma era un vissuto che come tale reclama il suo diritto a riapparire dalle ombre del passato.
Ed ecco [foto 3] il villino con tutte le finestre aperte, nel rispetto di norme igieniche per cui in certe ore del giorno la casa andava arieggiata e dentro qualcuno diligentemente sbatteva cuscini e materassi e la padrona di casa si dava da fare a controllare che nella dispensa non scarseggiassero i generi di prima necessità.
Se le targhette sono sparite (ma non siamo andati a controllare portone per portone), qualche cancello è ancora rimasto e i giardinetti e il colore uovo battuto sono tuttora visibili.

Ma poi anche gli spazi urbani hanno la loro storia. Spariscono i lumi a gas, le strade vengono asfaltate e risuonano di voci e rumori diversi.
Eppure per lungo tempo le vie attorno a piazza Caprera si sono avvantaggiate di una situazione che ha protetto la stessa piazza da un traffico invasivo, facendone uno scenario particolarmente adatto alle riprese cinematografiche. Si sceglievano angoli della città non invasi da auto in sosta, volendo molto spesso il regista raccontare un passato fatto di carrozzelle o di auto d’epoca, con lo strillone che vendeva l’edizione straordinaria di un qualche giornale. E si andava a girare nella bella stagione la mattina presto, ovvero di notte con i riflettori che fingevano il chiarore dell’alba o la luce diffusa del tramonto. Fino a qualche decennio fa era infatti possibile trovare qualche angolo di una piazza in quelle ore semideserta, come piazza Caprera, e disporvi oggetti simbolo d’un’epoca trascorsa e che l’aiuto-regista aveva impiegato tempo e sforzi per ritrovare. Erano carrettini di mercato, organini manovrati a manovella, biciclette un po’ sgangherate che facevano colore.
Ecco perché Ettore Scola scelse proprio piazza Caprera per girarvi alcune scene di “C’eravamo tanti amati” prodotto nel 1974, un film delicatissimo, con un eccezionale cast di attori, che tanti giustamente considerano un omaggio alla gloriosa stagione del cinema neorealista da poco trascorsa.
Nel 1974 la piazza era diversa rispetto ad oggi. Al posto della fontana moderna recentemente costruita, e intorno alla quale fervono in questi giorni non poche discussioni, ce n’era una meno pretenziosa con una scultura al centro e un lampione. All’ombra di questo lampione un pittore di strada dipinge, nel film di Scola, degli angeli che a poco a poco prendono colore e dalla prima parte del film (ambientata ai tempi della lotta di Liberazione e della ricostruzione post-bellica) in bianco e nero si passa a alla seconda, dove la pellicola a colori accentua le note drammatiche di un tempo che sembra ormai dover travolgere la vita dei protagonisti della storia, segnandone il destino, ben oltre le speranze, i sogni e e le illusioni di ciascuno di loro.
Una morale che torna anche sul discorso di una bella piazza dove oggi bivaccano nei fine settimana vandali neanche tanto in erba. La vita corre veloce e le stupidaggini che si fanno prima o poi si pagano. Il tempo perso bighellonando o facendo “bravate”, è perso per sempre in barba a ogni perdonismo e innocentismo che salva dalla vergogna dei giovani un po’ fessacchiotti. D’altro canto è storia che si ripete. Ed è proprio per questo che non si dovrebbe procedere di male in peggio.
Per me piazza Caprera era quella che si vedeva da lontano all’uscita dal Giulio Cesare di via Malta, destinata alle ragazze. Noi, che ci sentivamo uomini intraprendenti, uscendo di corsa dai cancelli principali di corso Trieste, ci affrettavamo ad accogliere le ragazze col più accattivante dei sorrisi, che, a dirla tutta, non ci salvava dal rischio d’assumere un’ espressione un po’ da ebeti.
Ricordo benissimo d’aver assistito proprio lì a una scazzottata come si deve tra un mio compagno e un suo rivale che si squadrarono l’un l’altro, quindi inarcando le schiene, iniziarono a darsele di santa ragione. E lei? La lei in questione si allontanò, senza degnare di alcuna considerazione né l’uno né l’altro dei due contendenti che erano scesi in lizza per guadagnarsi non dico chissacché ma almeno un sorriso da parte della bella.
Due poveri fessacchiotti, forse oggi professionisti di strillo, chissà! Non escludo infatti che qualcosa abbiano imparato da quell’errore, se non altro che errare humanum est.
Ma il gusto dell’errore per amore dell’errore non lo capisco.