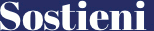Quando accompagnavo mia madre al mercato di viale Eritrea, popolato da orchi e giganti
Era un pianeta diverso. E quanto più eri bambino, tanto più sentivi d’essere immerso in una realtà tutta particolare. Non erano molte le occasioni per entrare nell’orbita di quel pianeta misterioso che era il mercato rionale del quartiere in cui ho vissuto bambino.
Andavo a scuola, alla Ugo Bartolomei di via Asmara a pochi passi da casa, e solo in qualche occasione mi affacciavo a quel mondo misterioso e affascinante mentre – devo dire – non lo era, o lo era assai poco, quello della scuola. Oggi, dopo una vita dedicata all’insegnamento, devo dire che è del tutto normale l’interesse che Pinocchio aveva per quanto gli appariva sotto agli occhi nel tragitto tra casa e scuola. La scuola, per come è stata per lungo tempo proposta agli italiani, è un luogo di lavoro e per qualcuno addirittura di pena.
A rendere triste l’ambiente scolastico, dove ho imparato dalle aste al periodo ipotetico fino a comporre un messaggio comprensibile, basti pensare che Ugo Bartolomei, come ci fu spiegato (nel senso che ci fu fatto intendere) era stato uno sfigatissimo sottotenente dell’esercito italiano che aveva trovato la morte, durante la prima guerra mondiale, cinque giorni prima della firma dell’armistizio, quello annunciato dallo storico bollettino compilato da Armando Diaz il 4 novembre 1918. Lo storico comunicato ufficiale concludeva sostenendo che “i resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano discese con orgogliosa sicurezza”. In quei resti s’era imbattuto il giovane Bartolomei, uno dei ragazzi del ’99, rimasto ucciso in combattimento.
Inutile dire che noi bambini, ogni 29 ottobre, sfilavamo in ordine a rendere omaggio a questo signore, sostando pensierosi davanti al suo busto posto nell’atrio della scuola. Cerimonia tristissima. E ricordo, fra l’altro, l’impressione che quel busto, attorno al quale compivamo un mezzo giro per arrivare alle scale che portavano alle aule, dava anche negli altri giorni dell’anno a noi bambini che sapevamo in quali circostanze il poveretto avesse perso la vita.
A scuola c’erano i turni e a volte io andavo a lezione il pomeriggio.
Nelle mattine libere, dopo aver fatto i compiti, capitava che accompagnassi mamma a comprare qualcosa e quando avevo la bicicletta con le ruote sgonfie o coi freni allentati, ne approfittavo per portarla dal vecchietto di via Sabrata che faceva il miracolo di riparare i freni e di gonfiare le gomme che diventavano tanto dure da farmi temere che potessero scoppiare da un momento all’altro.
Il mercato era più divertente quando ci andavo con la colf che allora si chiamava cameriera ovvero donna di servizio e che letterariamente diventava con facilità la “tata”, mentre si trattava di una laboriosa e paziente tuttofare che sbrigava un po’ tutte le faccende domestiche, conquistandosi la fiducia dei datori di lavoro che ancora a quell’epoca si chiamavano padroni. Pochi passi e, superata la prima fila di bancarelle, ti sentivi come rapito in quel mondo di odori tante volte gustosi ma anche penetranti, e di voci di un dialetto romanesco che sapevano delle più diverse inflessioni non sempre riconoscibili, dei dintorni di Roma. Quel mondo, variegato di colori, si schiudeva magicamente al mio sguardo.
Era il mercato di viale Eritrea, che si estendeva da piazza Annibaliano fin quasi a piazza Emerenziana e che fu chiuso quando aprì l’attuale mercato coperto di piazza Gimma. Si trattava nella mia memoria di una lunga fila di banconi al centro della via, in quell’ampia area di spartitraffico dove oggi c’è un parcheggio a spina di pesce da una parte e dall’altra del viale. Dietro i banconi c’erano omaccioni robusti dal fare spicciativo che però più ci tornavi, più erano cortesi o si sforzavano di esserlo. Se la voce era generalmente arrochita, come impone che nella vecchia Roma sia una voce da omo, non mancavano cenni rispettosi di saluto e tu guardavi con meno trepidazione questa specie di orchi che pareva si fossero dati convegno al mercato di viale Eritrea. Di loro non ebbi più soggezione quando mi accorsi che per andare al bancone salivano su una pedana che li faceva più alti di almeno dieci o quindici centimetri. Cosa che rimosse dalla mia testa l’idea che potessero essere dei giganti cattivi.
Nel pomeriggio vedevi spostarsi qualche carrettino, segno che il mercato, a fine giornata in disarmo, si avviava alla chiusura.
C’era il banco del fornaio, dove si rimediava a “gratise”, come si dice a Roma, una strisciolina di pizza, che mamma mi rifilava in bocca, tanto per impedirmi di fare troppe domande. Ma credo che per me parlassero gli occhi, per cui davanti a qualche prelibatezza, il bancarellaro di turno proponeva a mia madre l’acquisto di questo o di quello. E il “questo” poteva essere una banana, una manciata di fragole, quando c’erano; e il “quello” un pasticcino, ma anche la cartina per preparare l’acqua frizzante, la famosa idrolitina del cavalier Gazzoni, con le due bustine colorate.
Era al mercato di viale Eritrea che scoprivi che il pizzicarolo aveva, di prammatica, la matita all’orecchio e la matita aveva un pezzo di spago che l’avvolgeva o un elastico. Quando era il momento del conto il pizzicagnolo afferrava la matita, intingeva, se non religiosamente, certo ritualmente, la punta del lapis nella punta della lingua, per farla scorrere sul retro della carta oleata, che era un po’ unta, e annotava il prezzo della merce da pagare: il salame, le olive, il prosciutto e magari il formaggio.
Poi si passava ar banco der macellaro e qui, dopo brevi conversari sul taglio di carne da acquistare, c’erano le lame dei coltelli che si sfregavano l’una contro l’altra in un tintinnio che ricordava gli “sguisc, sguisc” del “cappa e spada” che allora imperversava alla tv. E il barone di Sigognac, all’epoca interpretato da Arnoldo Foà, smessi i panni del commediante Capitan Fracassa si presentava al rivale come “barone di Sigognac”, intimando in un sogghigno feroce: “In guardia”. L’altro, imbarazzato e intimidito, finiva per essere infilzato come un pollo allo spiedo. E il pollo era allora la carne del giorno di festa, quando io lasciavo volentieri alle sorelle il petto più delicato preferendo addentare la coscia. Devo ammettere che al mercato di viale Eritrea la fantasia correva di banco in banco.
Da allora sono passati tanti anni e oggi, per la carne mi rifornisco alla macelleria Amici in via Salaria 266, tra le più note del quartiere, a pochi passi da dove attualmente abito.  Parliamo di una macelleria storica che è a via Salaria dal 1977 e che nel 1963 aveva aperto i battenti a via Tirso. Una parola tira l’altra, chiedo, tempo fa, di conoscere la storia della macelleria e con con mia sorpresa scopro che Lionello Amici, padre del signor Ferruccio, attuale proprietario e conduttore di questo esercizio commerciale, aveva aperto il banco proprio a viale Eritrea nell’ormai lontano 1949.
Parliamo di una macelleria storica che è a via Salaria dal 1977 e che nel 1963 aveva aperto i battenti a via Tirso. Una parola tira l’altra, chiedo, tempo fa, di conoscere la storia della macelleria e con con mia sorpresa scopro che Lionello Amici, padre del signor Ferruccio, attuale proprietario e conduttore di questo esercizio commerciale, aveva aperto il banco proprio a viale Eritrea nell’ormai lontano 1949.
“Ma no, non ci credo. È impossibile”, ho pensato davanti alla faccia imperturbabile e severa di Michele Lambertini che lavora da ben quarant’anni nella macelleria Amici, mi indicava la gigantografia posta all’interno del locale, riproduzione d’una foto dell’epoca scattata in occasione dell’inaugurazione del banco. Devo ammettere che è stata un’emozione. La foto campeggia all’angolo del grande bancone frigorifero, dove sono esposti i vari tagli di carne a disposizione della clientela. Ed è notevole il contrasto fra l’ora e l’allora. Ora siamo in un negozio che non esiterei a definire di lusso. Allora davanti a un semplice bancone dove Lionello Amici, al centro, accanto alla moglie Silvana Ferrari è circondato da parenti e lavoranti.
Eppure già allora c’era la consapevolezza che la pubblicità fosse l’anima del commercio e su questo piano ci si arrangia. Bisogna ammettere che le due scritte simmetriche “Carni finissime” e “Vitella speciale” con al centro le iniziali del titolare del bancone non sono niente male e che insomma Lionello aveva le idee chiare e desiderava andare avanti. Anche queste piccole cose ci riportano a quegli anni della ricostruzione del Paese che dobbiamo alla caparbietà e all’impegno dei tanti che hanno lavorato, e duramente, in un dopoguerra segnato da delusioni, lutti, macerie e drammatici ricordi.
Anche queste piccole cose ci riportano a quegli anni della ricostruzione del Paese che dobbiamo alla caparbietà e all’impegno dei tanti che hanno lavorato, e duramente, in un dopoguerra segnato da delusioni, lutti, macerie e drammatici ricordi.
Nelle riprese fotografiche dell’amico Gregorio Chimienti realizzate oggi si vedono l’esterno e l’interno della macelleria, con la foto commemorativa dell’evento che risale a 71 anni fa. Purtroppo, nonostante la bravura del fotografo, qualche dettaglio è confuso perché la foto è incorniciata con un vetro e il gioco dei riflessi non consente più di tanto una perfetta visione. Ma chiunque lo voglia, può vedere con i suoi occhi il cimelio posto, come ho già detto in bella vista, dietro al bancone.
Risale invece al 1947 un’altra foto che mi è stata messa a disposizione dal signor Ferruccio. La foto mostra suo padre Lionello (baffuto e stempiato), “romano de Roma”, come mi viene precisato, e figlio a sua volta di macellaio, con i suoi primi tre figli che sono da sinistra a destra, Guglielmo Maria, Ferruccio ed Edvige.

È stato come se immagini sfocate riprendessero colore e forma. E sono tornato per incanto a quando, tenuto per mano da mia madre, mi affacciavo al mondo che si schiudeva ai miei occhi attoniti e pensosi.