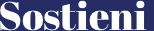17 Giugno 2022 - 17:48
Donazioni di sangue, Volterrani: “Ripartire dal senso di comunità. Nei quartieri romani si può”

di Daniele Magrini
La pandemia ha lasciato strascichi preoccupanti anche in quel sistema della donazione del sangue, che pure nel nostro Paese ha garantito l’autosufficienza. Ma con troppe differenze fra regione e regione. Tra le zone più problematiche c’è il Lazio. E Roma in particolare, dove tre autoemoteche non possono più rappresentare quella capillarità di presenza nel territorio che è elemento basilare per le donazioni. Senza un’azione capillare che risvegli lo spirito di comunità dei quartieri, a Roma la battaglia del sangue è persa in partenza.
Quanto la situazione rischi di diventare preoccupante lo dimostrano anche i dati resi noti dalla Fondazione Veronesi in merito alla donazione di plasma. Ogni mille abitanti la raccolta attraverso le donazioni del sangue è pari a 24 chili in Friuli-Venezia Giulia, poco meno nelle Marche o in Emilia-Romagna. Nel Lazio invece non si superano i 7,7 chilogrammi per mille abitanti. E Roma contribuisce in modo decisivo a questa performance preoccupante. Si tratta di uno dei dati più bassi, ben lontano anche dai 18 chilogrammi ogni mille abitanti che rappresentano la media nazionale.
Senza allarmismi, ma il trend attende inversioni di tendenza. A livello nazionale il calo fisiologico durante la pandemia è stato recuperato in larga parte grazie a 1.653.268 donatori, di cui il 92% iscritti alle associazioni di volontariato, volano del sistema-donazione, che rende possibili trasfusioni per circa 1.800 pazienti al giorno. Un quadro significativo, illustrato da Vincenzo De Angelis, direttore del Centro nazionale sangue, in occasione della Giornata mondiale dei donatori di sangue, che però ha inserito un elemento di preoccupazione: “L’Italia, che pure ha una situazione migliore del resto dell’Europa, è costretta a importare plasma dagli Usa”.
Il rischio che alcuni interventi chirurgici soprattutto nei grandi ospedali si debbano rinviare per carenze sul piano trasfusionale comincia a paventarsi. Perché, come ha notato il presidente della Croce rossa italiana, Francesco Rocca, per effetto della pandemia, “le regioni più efficienti sul piano delle donazioni, non riescono più a compensare il deficit di quelle dove la donazione va a rilento”.
E se è vero, come spesso sottolineato dal presidente dell’Avis Gianpietro Briola, che “l’autosufficienza di sangue dell’Italia deve essere la somma di autosufficienze regionali”, appare evidente quanto ci sia da lavorare nel Lazio. E soprattutto a Roma: se una città di quasi tre milioni di abitanti riuscisse a tenere il passo delle donazioni che ha il Friuli-Venezia Giulia (39,5%) o se come a Trento, un romano su tre fosse donatore di sangue, si capisce che ogni problema di approvvigionamento sarebbe superato. Che fare, dunque? Ne abbiamo parlato con Andrea Volterrani, sociologo dell’Università di Tor Vergata, che nei giorni scorsi è intervenuto all’incontro organizzato da Avis nazionale a Roma.
Professor Volterrani, perché nella Capitale sono così bassi i dati sulla donazione del sangue? Ovviamente ciò che le chiediamo va oltre il dato meramente strutturale…
“Però dalla situazione strutturale è bene partire. Non è certo possibile gestire la raccolta di sangue cittadina con tre autoemoteche che si muovono da zona a zona. E certamente recarsi nelle strutture sanitarie comporta problemi logistici di accesso, a cominciare dal traffico e dal tempo perso per parcheggiare. Ma dobbiamo andare ben oltre per capire quello che è un deficit di carattere sociale. Roma è fatta di tanti quartieri che rappresentano tante piccole e medie comunità. È in questi territori oggi largamente inesplorati che dobbiamo cominciare a lavorare. Qualche anno fa è uscito un libro del professor Roberto Cartocci. Si intitolava Mappe del tesoro – Atlante del capitale sociale in Italia. La ‘ricchezza’ sociale diminuiva dalla Toscana in giù. Salvo la provincia di Ragusa, in Sicilia, dove un manager umbro che si era trasferito aveva portato i metodi di aggregazione sociale della sua regione, con evidenti risultati positivi. Il tema vero, oggi a Roma, soprattutto a Roma, è il recupero di quel capitale sociale che è andato disperso, riattivando un sistema di relazioni che appare disgregato. Il tema della donazione del sangue è un asset di questo lavoro sul territorio da intraprendere”.
Da dove si comincia?
“Dai quartieri romani. Lì bisogna andare e in modo non episodico. Perché ogni quartiere è una media città che ha proprie caratteristiche, proprie abitudini e relazioni da far riemergere dalla frammentazione. Entrare in contatto con quelle comunità, puntando alla riemersione della coesione sociale, alla cultura del dono, per abbandonare dinamiche individualiste. La deriva è quella di chi ragiona in chiave di soluzione personale: devo fare un intervento chirurgico, i miei parenti donano il sangue e il problema è risolto. Non è così, bisogna ragionare in termini di comunità: i ragionamenti privatistici non si addicono alla donazione. Si deve andare nelle piazze, nei circoli, nei luoghi di aggregazione dei vari quartieri, lavorare porta a porta per riallacciare i fili delle relazioni sociali”.
In certi quartieri potrebbe essere più facile? Penso a zone che nell’immaginario collettivo hanno una forte identità, come Testaccio, Quadraro, Garbatella…
“Certo, un quartiere come il Quadraro, che ha radici di forti aggregazioni valoriali a cominciare dall’impegno nella Resistenza, pare avere un humus dove nuove spinte di coesione possano attecchire più facilmente. Anche perché chi sta in questo o in altri quartieri, dentro questo microcosmo (neppure tanto micro) vive. Non va in centro. Non si muove. Ed è qui dunque che le persone vanno cercate. Perché la ricchezza del capitale sociale la fanno le persone. E ogni quartiere romano è una città dove lavorare con nuovo impulso. Penso a San Basilio, a Tor Bella Monaca. Senza presupporre che esistano territori migliori e peggiori, perché anche le comunità che apparivano più coese non lo sono più. Basti pensare che tra i dati di raccolta del sangue in calo, ci sono quelli di zone come la Toscana”.
Chi lo deve fare questo lavoro sul territorio per superare il deficit nella donazione del sangue a Roma?
“Proprio le associazioni storicamente impegnate sono le più adatte per questi progetti di nuove coesioni, che dovrebbero essere calibrati su ogni singolo quartiere, a partire dalle specificità sociali, dalle caratteristiche demografiche, tenendo anche conto del fatto che esiste un gap da sanare sul fronte della donazione del sangue, che è quello del ricambio generazionale. Le associazioni dovrebbero battere palmo a palmo i quartieri, incontrando le persone, spiegando le modalità delle donazioni, facendo capire che si tratta di un bisogno sociale al quale si possono dare risposte condivise e non individuali”.
I social, la Rete, possono aiutare in questa penetrazione territoriale?
“Le piccole e medie città che messe insieme fanno Roma, cioè i quartieri, vanno sollecitati attraverso la relazione tra persone. Questa crea coesione e può spingere verso una riaffermazione valoriale della donazione del sangue. Gli spazi digitali possono aiutare ma se vanno ad aggiungersi alla relazione off line senza sostituirla”.
Esistono progetti già avviati nella direzione che lei indica?
“Abbiamo fatto e stiamo facendo esperienze di costruzione di comunità al Sud, a Santa Severa, a Gela, nel quartiere Pellaro di Reggio Calabria. Ne abbiamo scritto insieme al collega Luciano Squillaci nel libro Lo sviluppo sociale delle comunità. Come il terzo settore può rendere protagoniste, partecipative e coese le comunità territoriali. Il volontariato è fondamentale per partire dal basso nella ricostruzione di una trama di comunità. Farlo a Roma, con l’obiettivo di incentivare la donazione del sangue, dovrebbe essere più facile rispetto a realtà in cui spesso siamo a sgomitare con organizzazioni che le reti sanno crearle, ma per finalità criminali”.
La sua analisi induce a pensare che siano necessari processi in cui si cerca di invertire la tendenza alla liquidità sociale, riattivando avamposti di relazione territoriale. In questo senso quello della donazione dal sangue può essere un terreno ideale di sperimentazione sociale?
“Non parlerei di sperimentazione ma di riattivazione del capitale sociale superando la frammentazione delle relazioni. Certo, quello della raccolta del sangue pare un terreno ideale, perché è un obiettivo concreto e valoriale insieme: servono migliaia e migliaia di sacche di sangue per salvare vite umane. E servono persone che facciano comunità nei loro quartieri. A Roma, i quartieri rappresentano tante città da riaccendere. Non sarà facile. Ma vale la pena provarci”.
LEGGI: Roma, sangue e plasma sempre più scarsi